
Tecnica e pittura, iperrealismo e comunicazione
Quando si parla di pittura, fin dai tempi più antichi, gira e rigira spesso si finisce a dibattere su questo annoso argomento: il pittore deve saper rifare la realtà esattamente come appare e come lo vedono tutti?
Nell’antica Grecia toccò a Parrasio e Zeusi ingannare mosche e persone con uva e tende. Michelangelo lodò sé stesso prendendo a martellate il suo Mosè perché sprovvisto di parola e così via.
In sintesi, la capacità di imitare perfettamente la realtà è meritevole e indice di talento e capacità tecniche.
Oggi, grazie anche a robusti aiuti tecnici come Photoshop, tablet, ingranditori, fotografia ecc., realizzare un dipinto perfettamente simile alla realtà è alla portata di quasi tutti. Tempo, applicazione (la famosa regola delle 10.000 ore, con le dovute premesse) e un minimo di capacità vi assicurano il risultato.
Sono sempre più frequenti, nei social e nelle news, immagini che sembrano fotografie dettagliatissime e che, invece, sono “fatti a mano” (o quasi) da pittori “iper-realisti”.
L’iper-realismo nasce verso gli anni ’70 come reazione al mondo dei media sotto il nome “fotorealismo”; sarà poi il gallerista Louis K. Meisel a inventare il nome “iper-realismo”.
Perché “iper”?
Com’è noto l’occhio umano non è in grado di cogliere i particolari e i dettagli della realtà. Il processo della visione è come un gigantesco “puzzle” mentale risolto in frazioni di secondo dalla nostra mente ,unendo le immagini che gli occhi raccolgono saltabeccando veloci da un punto all’altro della realtà.
In questi quadri o stampe i dettagli, invece, sono nitidi e precisi in ogni parte dell’immagine e perciò la visione è superiore alla realtà stessa.
I pionieri di questa disciplina furono Paul Cadden soprannominato “il fotografo a matita” che ricopiando fotografie, soprattutto di volti rugosi che facilitano l’effetto “Wow!”, espone il suo talento.
Richard Estes è specializzato in cabine telefoniche cromate e viste metropolitane a colori.
Il nostrano Luciano Ventrone, pupillo del compianto critico d’arte Federico Zeri, preferisce cesti di frutta e angurie spaccate.
Gregory Thielker si diletta a realizzare quadri come fossero coperti da un vetro bagnato pieno di goccioline.
Tutti virtuosi di una tecnica che da un lato stupisce e meraviglia come un gioco di prestigio, ma che nella sua massima espressione ha come risultato “essere come una fotografia”.
Mi rammenta una battuta che l’attore Laurence Olivier rivolse a Dustin Hoffman durante le riprese del “Maratoneta”.
A volte si ritardavano le riprese perché Dustin Hoffman voleva correre per chilometri per “calarsi nel personaggio”, per essere “vero”.
Al ché Olivier gli disse: “Dustin, basterebbe recitare”.
Il collegamento con il discorso sull’iper-realismo è: dove porta questo modo di dipingere?
Avere padronanza del mezzo tecnico è indispensabile per potersi esprimere, ma se il virtuosismo è fine a sé stesso quale è il senso?
Prendiamo a esempio i “Girasoli” di Vincent Van Gogh: dipingerli dettagliando fino al più intimo colorino del pistillo avrebbe aggiunto o tolto espressività all’immagine?
E cosa ci comunica la copia fotografica dei semini d’anguria in un quadro di Ventrone?
Voglio chiudere raccontando un episodio personale accaduto nella seconda metà del secolo scorso.
In quel tempo frequentavo il liceo artistico di Brera perché dopo aver vinto per ben due anni il concorso parrocchiale di disegno e aver raccolto il tradizionale “…ma l’hai fatto tu?” dai parenti a cui mostravo i miei disegni, la mia vocazione era chiara.
In classe c’ero io e un mio compagno Bruno, lui figlio e nipote di illustratori fumettisti, che sapevamo “copiare” dal vero.
Nelle ore di “ornato” (così si chiamavano le ore destinate al disegno libero senza modelle), dopo le “tavole” obbligatorie di programma, ognuno poteva scegliere come perfezionarsi e io e Bruno decidemmo di continuare a “copiare” immagini, prendendo delle fotografie suggestive e dipingendole a tempera o pastelli secondo soggetto, ma rigorosamente uguali all’originale.
La professoressa, una scenografa molto giovane e tutt’ora in professione nei teatri di tutto il mondo, che pur non aveva interferito con le nostre scelte, un giorno passando a controllare il lavoro ci disse: “Quando smetterete di fare i pappagalli e inizierete a cantare la vostra canzone sarà un bel giorno.”
Era chiaro dalla parola “pappagalli” che era una critica, ma sinceramente non mi era molto chiara l’esortazione.
Andai a chiedere giustificandomi: “Ma professoressa, io mi sto allenando a dipingere bene”
Risposta “E cosa vuoi raccontarmi di diverso da quanto mi dice quella foto?”
Voleva mettermi in crisi? Ci riuscì in pieno.
Arrivare in classe nelle ore di “ornato” e copiare fotografie, che modestamente mi veniva molto bene, era facile. Non avevo nemmeno bisogno di pensare. Era come disegnare un “mandala” o riempire quegli album da disegno coi numeretti.
Ma se dovevo raccontare qualcosa, non avevo scampo: dovevo collegare il cervello.
E, cosa ancor più impegnativa, avere qualcosa da raccontare.
Quel giorno finì la mia carriera di foto-copiatore e iniziò quella di studente di pittura e arte.
Non ho nessuna verità sulla mia tavolozza, ma quel giorno mi fu dato un criterio in più per capire l’arte della pittura.

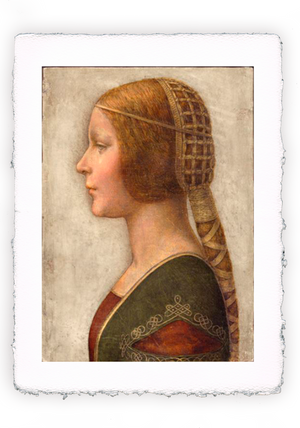
Lascia un commento